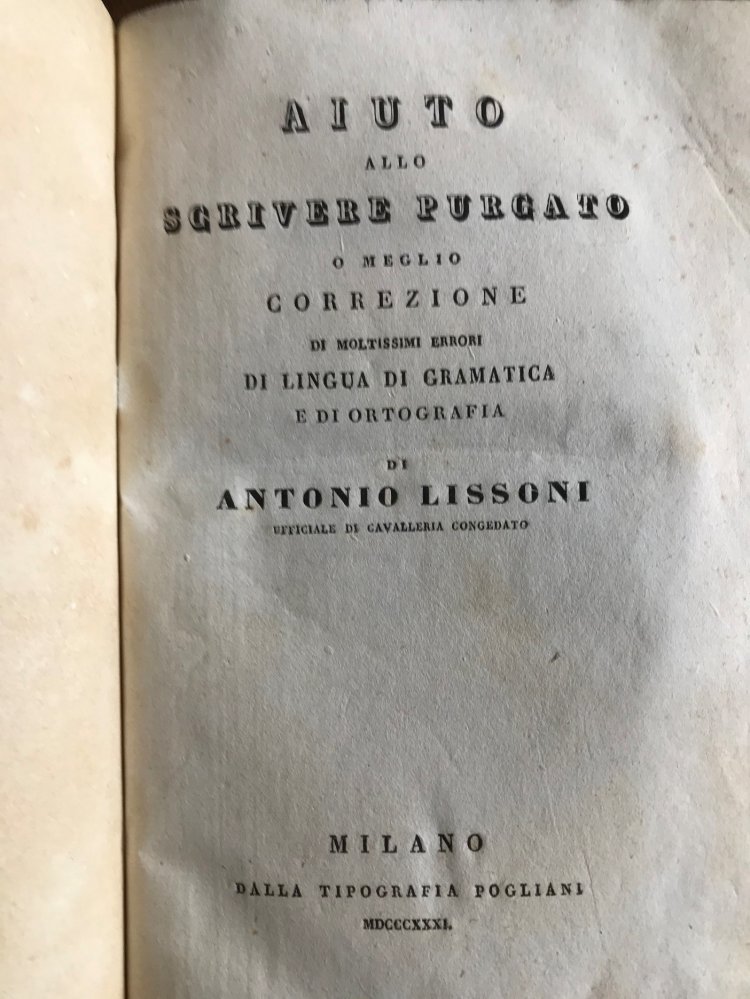
Vuolsi così colà dove si puote
ciò che si vuole: e più non dimandare.
(Inferno, III, 95-96)
Nel settembre del 2011 il Comitato per la legislazione della Camera dei deputati promosse un seminario dal titolo La buona scrittura delle leggi, i cui atti furono raccolti in un ponderoso volume[1] che illustra – attraverso i contributi di autorevoli linguisti, giuristi e parlamentari – come la buona qualità del linguaggio legislativo costituisca veicolo di attuazione del principio democratico di certezza del diritto e della certezza dei diritti dei cittadini; il volume è ricco di indicazioni utili per conseguire obiettivi di chiarezza, efficacia e coerenza dei testi normativi.
Quasi un anno dopo, nel giugno 2012, quel volume non doveva ancora averlo letto nessuno dei nostri parlamentari, almeno a giudicare dalla sciatteria e dall’approssimazione con le quali la legge 28 giugno 2012 n. 92 (Riforma Fornero) ha riscritto l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.
L’abisso dell’oscurità linguistica e giuridica è stato raggiunto, probabilmente, dal nuovo testo dell’art. 18, 7° comma, seconda parte, dove il legislatore del 2012 ha stabilito che il giudice «può altresì applicare la predetta disciplina (la “disciplina di cui al quarto comma del presente articolo”, ossia la tutela reale “attenuata”, che contempla la reintegrazione nel posto di lavoro ma limita a dodici mensilità di retribuzione l’importo dell’indennità risarcitoria che il datore di lavoro è obbligato a corrispondere, detratti l’aliunde perceptum e l’aliunde percipiendum) nell’ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo».
L’infelice formulazione della norma ha immediatamente destato sconcerto tra i commentatori[2], sia per l’imprecisione costituita dall’ambigua nozione di «fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo», sia per il ricorso all’illogica categoria della «manifesta» insussistenza del fatto, sia, infine, per l’inedito utilizzo del verbo «può» in relazione alla risposta sanzionatoria data dal giudice alla condotta illegittima del datore di lavoro.
Se in relazione al licenziamento disciplinare (per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo) è relativamente facile individuare il “fatto” la cui sussistenza o meno determina la legittimità o l’illegittimità del licenziamento (si tratterà, normalmente, della condotta illecita addebitata al lavoratore), risulta veramente arduo, viceversa, enucleare il “fatto” giustificativo del licenziamento per ragioni economiche dal complesso intreccio, inevitabilmente valutativo, che sorregge la decisione datoriale di sopprimere un posto di lavoro, intreccio nel quale confluiscono le «ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa» (art. 3 L. 604/1966), il nesso causale tra quelle «ragioni» e la soppressione del singolo posto di lavoro, l’impossibilità di adibire il lavoratore che vi era addetto ad altre mansioni, anche inferiori, ed infine i criteri di correttezza e buona fede da applicare in caso di licenziamento di uno solo tra più lavoratori addetti a mansioni fungibili.
Il «fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo», dunque, non è un fatto materiale, storicamente accertabile, ma è un “fatto” da intendersi in senso giuridico, come un giudizio di relazione tra diversi elementi di fatto, ragioni e scelte, che comporta una valutazione complessiva circa la loro consistenza e consequenzialità.
Risulta, quindi, incongruo riferirsi al «fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo» in termini di sussistenza o di insussistenza: di un giudizio di relazione, di valore e di causalità non si può predicare la “sussistenza” o meno ma, semmai, se ne potrà affermare la fondatezza, la persuasività o, viceversa, l’infondatezza, l’erroneità.
Con riferimento ad un licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo, dunque, l’«insussistenza del fatto» – alla quale consegue non già la reintegrazione, ma solo la corresponsione di un’indennità risarcitoria compresa tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità – dovrebbe aversi quando risulta assente anche uno solo degli inscindibili presupposti di legittimità del licenziamento: perché, ad esempio, la riorganizzazione aziendale non c’è stata, il posto di lavoro non è stato realmente soppresso ed è stato assunto un nuovo lavoratore per svolgere le stesse mansioni, o manca il nesso causale con il recesso, o il datore di lavoro ha violato l’obbligo di repêchage, o ha male applicato i criteri di scelta tra lavoratori fungibili.
Il tenore letterale del novellato art. 18, 7° comma, è poi in contrasto frontale con la logica quando pretende di graduare l’insussistenza del “fatto”, fino ad individuare ipotesi in cui si dovrebbe poter accertare la «manifesta insussistenza» del fatto. Non occorre scomodare Parmenide di Elea (VI-V sec. a.C.) ed il suo celebre «L’Essere è e non può non essere; il Non Essere non è e non può essere» per rendersi conto che un fatto o “sussiste” o “non sussiste” e che, rispetto ad un fatto che non sussiste, non ha alcun senso provare a distinguere tra insussistenza tout court e insussistenza “manifesta”; anche dal punto di vista processuale, poco importa che un fatto appaia insussistente ictu oculi, o solo all’esito di una faticosa istruttoria.
Se si considera, peraltro, che l’aggettivo «manifesto» è comunemente utilizzato nel linguaggio giuridico per designare la evidente infondatezza di questioni, eccezioni, motivi di impugnazione (v., ad es., l’art. 23 L. 87/1953 sulla non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale), cioè per qualificare l’infondatezza palese, immediatamente percepibile, di un ragionamento giuridico, si può tentare di collocare la «manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo» sul piano processuale, ossia come misura del grado di convincimento raggiunto dal giudice sulla fondatezza delle ragioni addotte dal datore di lavoro per giustificare il licenziamento: la «manifesta insussistenza del fatto», allora, sarebbe ravvisabile in presenza di elementi univoci, che dimostrino in maniera evidente la non veridicità, l’inconsistenza delle ragioni addotte dall’imprenditore.
Il volenteroso interprete che fosse riuscito ad arrivare fin qui, nel tentativo di raggiungere l’agognata meta della certezza del diritto, si trovava finora la strada sbarrata da un ostacolo veramente insormontabile: individuato faticosamente il «fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo» e riscontratane non solo l’insussistenza, ma la «manifesta insussistenza», il nostro eroe – sia esso lavoratore, imprenditore, sindacalista, avvocato, giudice – non poteva ancora prevedere quali sarebbero state le conseguenze giuridiche dell’illegittimità del recesso.
L’art. 18, 7° comma, riformato dalla legge Fornero, infatti, diceva soltanto che il giudice «può altresì applicare» la disciplina di cui al quarto comma dell’art. 18, ossia la reintegrazione nel posto di lavoro con l’indennità risarcitoria fino a dodici mensilità di retribuzione, il che significa che il giudice “poteva applicare” la tutela reintegratoria “attenuata”, ma “poteva anche non applicarla” limitandosi a sanzionare il licenziamento “manifestamente” illegittimo con la sola tutela indennitaria “forte”, da dodici a ventiquattro mensilità di retribuzione.
La norma non forniva al giudice alcun criterio o parametro, neppure generico, per orientare e giustificare l’esercizio del potere di applicare o non applicare la tutela reintegratoria, col duplice risultato di lasciare indeterminata la sanzione, affidandola alla discrezionalità legibus soluta o all’equità del giudice, e di rendere del tutto imprevedibile l’esito del giudizio.
Ora, finalmente, almeno quest’ultimo ostacolo linguistico alla certezza dei diritti è stato abbattuto dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza 1° aprile 2021, n. 59 (rel. Sciarra), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, settimo comma, secondo periodo, «nella parte in cui prevede che il giudice, quando accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, "può altresì applicare" – invece che "applica altresì" – la disciplina di cui al medesimo art. 18, quarto comma» (reintegrazione “attenuata”).
La meritoria ordinanza di rimessione era stata pronunciata dal Tribunale di Ravenna (ord. 7.2.2020), nell’ambito di un giudizio in cui, accertata l’illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo per manifesta insussistenza del fatto, il giudice si trovava a dover fare uso del potere discrezionale di scegliere se reintegrare o meno il lavoratore (e, dunque, se applicare la tutela reale “attenuata” di cui al quarto comma dell’art. 18, o la tutela indennitaria “forte” di cui al quinto comma).
Il giudice a quo aveva correttamente rilevato che la giurisprudenza di legittimità aveva cercato di dare un contenuto alla disposizione in questione, richiamando i «principi generali forniti dall’ordinamento in materia di risarcimento del danno, e, in particolare, dal concetto di eccessiva onerosità al quale il codice civile fa riferimento nel caso in cui il giudice ritenga di sostituire il risarcimento per equivalente alla reintegrazione in forma specifica (art. 2058 cod. civ., applicabile anche ai casi di responsabilità contrattuale) ovvero di diminuire l’ammontare della penale concordata tra le parti (art. 1384 cod. civ.). Il ricorso ai principi generali del diritto civile permette di configurare un parametro di riferimento per l’esercizio del potere discrezionale del giudice, consentendogli di valutare – per la scelta del regime sanzionatorio da applicare – se la tutela reintegratoria sia, al momento di adozione del provvedimento giudiziale, sostanzialmente incompatibile con la struttura organizzativa medio tempore assunta dall’impresa. Una eventuale accertata eccessiva onerosità di ripristinare il rapporto di lavoro può consentire, dunque, al giudice di optare – nonostante l’accertata manifesta insussistenza di uno dei due requisiti costitutivi del licenziamento – per la tutela indennitaria» (Cass. n. 10435/2018 e le successive conformi Cass. nn. 2930/2019 e 2366/2020; l’orientamento contrario, minoritario, propugnato da Cass. n. 7167/2019 secondo cui «l’espressione "può altresì applicare" non assegna al giudice un margine ulteriore di discrezionalità, posto che, ove il fatto sia caratterizzato dalla "manifesta insussistenza", è unica, e soltanto applicabile, la protezione del lavoratore rappresentata dalla disciplina del comma 4», non appariva convincente, proponendo un’interpretazione sostanzialmente abrogatrice di un testuale elemento normativo).
Così ricostruito il “diritto vivente”, il Tribunale di Ravenna ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, 7° comma, St. Lav. (“versione Fornero”), anzitutto per violazione dell’art. 3 Cost., per il trattamento discriminatorio riservato dalla norma a situazioni identiche, dal momento che il quarto comma dell’art. 18 prevede che nelle ipotesi in cui non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa, il giudice «annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria» fino a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, ossia il giudice è tenuto a disporre la reintegrazione.
Il rimettente osserva che tra un licenziamento per giustificato motivo oggettivo fondato su un fatto (manifestamente) inesistente e un licenziamento per giusta causa fondato su un fatto (semplicemente) inesistente non vi è una differenza ontologica, naturalistica, ma è soltanto la volontà del datore di lavoro che qualificare il licenziamento come recesso per giusta causa o per giustificato motivo oggettivo, e tale mera e insindacabile volontà datoriale non può fondare la differenza di trattamento sanzionatorio tra due licenziamenti entrambi basati su fatti accertati come inesistenti.
Il Tribunale di Ravenna ha censurato l’art. 18, 7° comma, anche per violazione dell’art. 41 Cost., perché la previsione di un potere discrezionale del giudice, peraltro nell’assoluta mancanza di criteri normativi in base ai quali orientare la scelta, concede al giudice un potere essenzialmente assimilabile all’esercizio dell’attività di impresa, in violazione dell’art. 41, 1° comma, Cost., in base al quale l’iniziativa economica privata è libera: l’atto espulsivo adottabile dal giudice all’esito del processo decisionale imposto dalla norma («può»), altro non è che un nuovo licenziamento per giustificato motivo oggettivo, deciso dal giudice, in luogo della reintegra prevista per altre situazioni identiche.
L’ordinanza di rimessione evidenzia, infine, il contrasto dell’art. 18, 7° comma, con gli artt. 24 e 111, 2° comma, Cost.: con l’art. 24 perché un lavoratore ingiustamente licenziato sulla base di un fatto inesistente si troverebbe davanti – dopo avere già dimostrato di avere ragione – un ulteriore avversario, il giudice, il quale avrebbe il potere di intimargli un nuovo licenziamento, senza consentirgli alcuna difesa, e privandolo di un grado di giudizio; con l’art. 111, 2° comma, perché fare assumere al giudice la decisione di espellere o meno un lavoratore che avrebbe altrimenti diritto alla reintegra significa fargli prendere le veci di una delle parti, il datore di lavoro, allontanandolo dal suo ruolo di terzietà, in violazione della regola del giusto processo.
La Corte Costituzionale ha, anzitutto, confermato l’assunto del giudice rimettente, avallato anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass., n.2366/2020), che la reintegrazione non sia obbligatoria, neppure quando l’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento si connoti come «manifesta», rilevando che al perentorio «applica» del primo periodo dell’art. 18, 7° comma, fa riscontro il «può applicare» del secondo periodo, che sottende una facoltà discrezionale del giudice.
Sulla base di questa premessa, la Corte ha riconosciuto che la disposizione censurata, nel sancire una facoltà discrezionale di concedere o negare la reintegrazione, contrasta con l’art. 3 Cost.
La sentenza in commento ricorda che l’esigenza di circondare di «doverose garanzie» e di «opportuni temperamenti» le fattispecie di licenziamento si fonda sulla tutela del lavoro sancita dalla Costituzione (art. 4, primo comma, e art. 35 Cost.) e dalle fonti sovranazionali (art. 24 della Carta Sociale Europea e art. 30 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea): si coglie qui, distintamente, l’eco della sentenza n. 194/2018 della stessa Corte Costituzionale che, dagli stessi artt. 4 e 35 Cost., trae l’affermazione che «i limiti posti al potere di recesso del datore di lavoro correggono un disequilibrio di fatto esistente nel contratto di lavoro. Il forte coinvolgimento della persona umana – a differenza di quanto accade in altri rapporti di durata – qualifica il diritto al lavoro come diritto fondamentale, cui il legislatore deve guardare per apprestare specifiche tutele».
Se è vero, dunque, che la reintegrazione non rappresenta «l’unico possibile paradigma attuativo» dei princìpi costituzionali (Corte Cost. n. 46/2000), è indubbio che il legislatore, nella scelta tra i «molteplici rimedi idonei a garantire una adeguata compensazione per il lavoratore arbitrariamente licenziato», è vincolato al rispetto dei princìpi di eguaglianza e di ragionevolezza.
Tali princìpi sono violati dall’art. 18, 7° comma, nella parte in cui prevede la mera facoltatività della reintegrazione per i soli licenziamenti economici – pur a fronte di una inconsistenza «manifesta» della giustificazione addotta e, quindi, di un vizio più grave della pura e semplice “insussistenza del fatto” – mentre, per i licenziamenti disciplinari, il legislatore ha previsto l’obbligo della reintegrazione in tutti i casi in cui si accerti l’“insussistenza del fatto” posto a base del recesso (art. 18, 4° comma).
La Corte rileva, infatti, che le peculiarità delle fattispecie di licenziamento – rispettivamente, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo in relazione alla violazione degli obblighi contrattuali del lavoratore, e per giustificato motivo oggettivo in relazione a scelte tecniche e organizzative dell’imprenditore – non legittimano una diversificazione quanto alla obbligatorietà o facoltatività della reintegrazione, una volta che si reputi l’“insussistenza del fatto” meritevole di essere sanzionata con la reintegrazione: l’esercizio arbitrario del potere di licenziamento, sia quando adduce a pretesto un fatto disciplinare inesistente sia quando si appella a una ragione produttiva priva di ogni riscontro, lede l’interesse del lavoratore alla continuità del vincolo negoziale e si risolve in una vicenda traumatica, che vede direttamente implicata la persona del lavoratore.
Tali elementi comuni alle fattispecie di licenziamento privano di una ragione giustificatrice plausibile la configurazione di un rimedio meramente facoltativo per i soli licenziamenti economici. Ne discende l’incostituzionalità dell’art. 18, 7° comma, per violazione del principio di ragionevolezza, e la necessaria applicazione della tutela reintegratoria “attenuata” in tutti i casi in cui il giudice accerti la «manifesta insussistenza» del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
La sentenza, peraltro, non si ferma qui, ed aggiunge che «è sprovvisto di un fondamento razionale» l’orientamento giurisprudenziale, sopra ricordato, che ha dedotto, dai principi generali dell’ordinamento in materia di risarcimento del danno, la possibilità di escludere la reintegrazione nel posto di lavoro quando risulti «eccessivamente onerosa» per il datore di lavoro, perché «sostanzialmente incompatibile con la struttura organizzativa medio tempore assunta dall’impresa» (Cass., n. 10435/2018 e le altre citt.).
L’eccessiva onerosità – secondo i giudici costituzionali – è un criterio indeterminato, privo di ogni attinenza con il disvalore del licenziamento e presuppone valutazioni comparative non lineari nella dialettica tra il diritto del lavoratore a non essere arbitrariamente estromesso dal posto di lavoro e la libertà di iniziativa economica privata; esso non aiuta nemmeno ad individuare parametri sicuri per la valutazione del giudice nella scelta tra due rimedi profondamente diversi – la reintegrazione o l’indennità risarcitoria – che non possono affatto essere considerati equivalenti ed ugualmente soddisfacenti per il lavoratore.
Inoltre, è un criterio che si presta a condotte elusive, perché il mutamento della struttura organizzativa dell’impresa che, secondo il recente orientamento della Cassazione, preclude l’applicazione della tutela reintegratoria, è rimesso alla volontà dello stesso imprenditore che ha intimato il licenziamento illegittimo: si offre così al debitore inadempiente l’occasione per rendere impossibile, ex post, il risarcimento del danno in forma specifica.
Anche da questo punto di vista, quindi, la Corte Costituzionale ravvisa l’irragionevolezza della disposizione censurata dal Tribunale di Ravenna.
Infine, pare interessante sottolineare come la Corte – pur confermando che il giudice, nell’accertamento della sussistenza del giustificato motivo oggettivo, è chiamato a valutare l’effettività della scelta organizzativa del datore di lavoro «senza sconfinare in un sindacato di congruità e di opportunità» – non manchi di precisare che «il vaglio della genuinità della decisione imprenditoriale garantisce che il licenziamento rappresenti pur sempre una extrema ratio e non il frutto di un insindacabile arbitrio». È forse troppo scorgere in questa riproposizione della tesi del licenziamento come extrema ratio una tacita critica all’orientamento – inaugurato da Cass., n. 25201/2016[3] e ormai incontrastato nella giurisprudenza di legittimità (v., tra le tante, Cass. nn. 4015/2017, 10699/2017, 13015/2017, 24882/2017, 12794/2018, 31158/2018, 828/2019, 19302/2019, 3819/2020, 15400/2020, 4894/2021) – secondo il quale il licenziamento per giustificato motivo oggettivo non richiede la prova di una situazione di difficoltà economica non contingente, o di crisi aziendale, che renda inevitabile la soppressione del posto di lavoro, ma può fondarsi anche su scelte organizzative dell’imprenditore finalizzate al solo incremento dei profitti o ad una migliore efficienza gestionale o produttiva dell’azienda?
[1] https://www.camera.it/temiap/temi16/La_buona_scrittura_delle_leggi.pdf
[2] Tra i tanti, v. F. Drago, Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo nel nuovo articolo 18 Stat. Lav., in QFMB Saggi/Ricerche, n. 3/2012; A. Vallebona, La riforma del lavoro 2012; T. Treu, Flessibilità e tutele nella riforma del lavoro, in Giornale dir. lav. e rel. ind., n. 137, 2013, 1; A. Perulli, Fatto e valutazione giuridica del fatto nella nuova disciplina dell’art. 18 St. lav. Ratio ed aporie dei concetti normativi, in Arg. Dir. Lav., 2012, 785; V. Speziale, La riforma del licenziamento individuale tra diritto ed economia, in Riv. It. Dir. Lav., 2012, I, 544; O. Mazzotta, I molti nodi irrisolti nel nuovo art. 18 dello Statuto dei lavoratori, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona". IT – 159/2012; C. Ponterio, Il licenziamento per motivi economici, in Arg. Dir. Lav., 2013, 73.
[3] V. C. Ponterio, Il nuovo orientamento della cassazione sul licenziamento per giustificato motivo oggettivo, su questa Rivista, https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-nuovo-orientamento-della-cassazione-sul-licenziamento-per-giustificato-motivo-oggettivo_08-02-2017.php

