La stampa promossa da Md. Il lungo viaggio da Quale giustizia a Questione giustizia
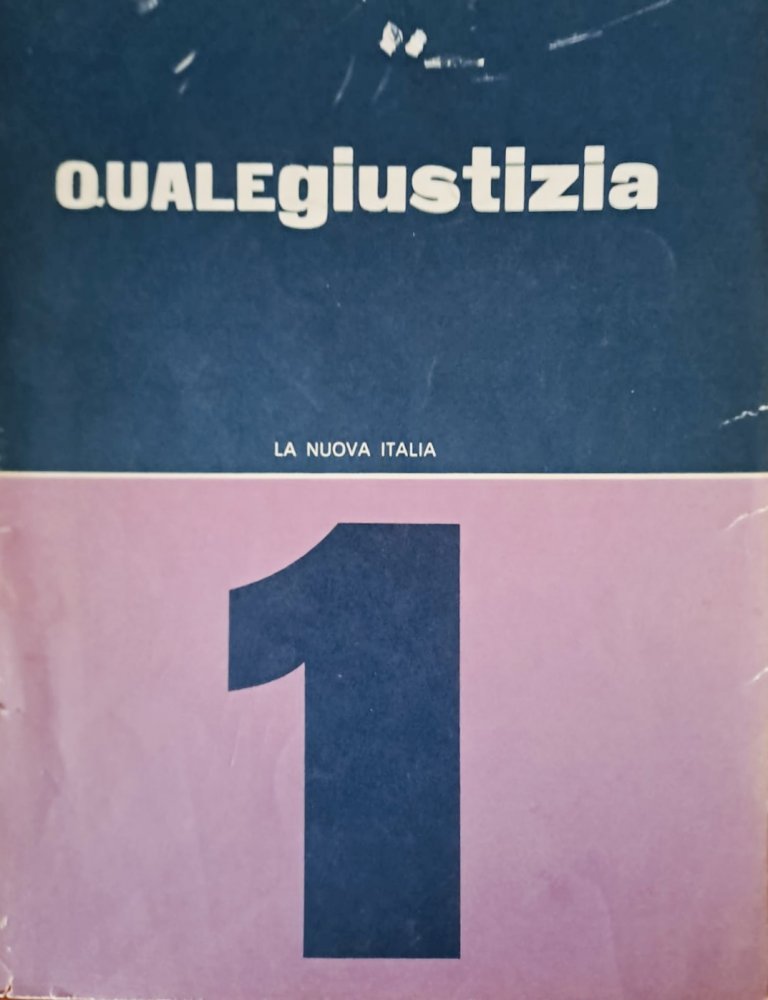
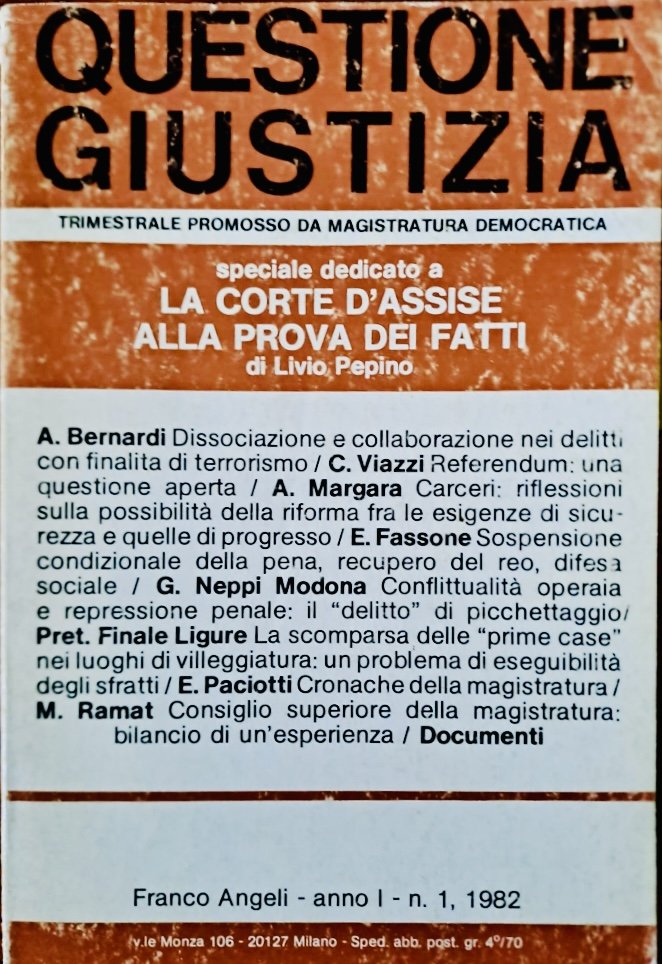
1. La distopia del Ministro della giustizia / 2. Un ponte tra passato e futuro / 3. I tratti di fondo della stampa “promossa” da Md / 4. L’esplosione policentrica all’inizio degli anni settanta. Quale giustizia, Magistratura democratica e le altre iniziative locali / 5. Questione giustizia e Omissis / 6. Il salto nel web
1. La distopia del Ministro della giustizia
Quella di oggi è una festa per i primi sessant’anni di vita di Magistratura democratica. E della festa deve conservare la vivacità e la gioiosità. Ma non può essere un “amarcord”.
La realtà esterna, con le sue durezze e le sue insidie, è troppo pressante, troppo incalzante.
Possiamo sorridere della goffaggine delle iniziative repressive del passato, qui più volte ricordate. Ma, al tempo stesso, occorre misurarsi con le altrettanto goffe ma non meno pericolose iniziative del presente.
E dalla storia, come sempre, possiamo trarre indicazioni e insegnamenti.
Nell’ambito della rievocazione degli aspetti principali dell’attività di Magistratura democratica, parlerò della stampa promossa dal gruppo, del lungo e fecondo esercizio di “intelligenza critica” compiuto dai magistrati sulla Costituzione, sulle leggi, sulle sentenze, in una parola: sul diritto.
Riflessione critica che costituisce un tassello insostituibile della nostra cultura giuridica, a dispetto dell’opinione enunciata qualche giorno fa al Salone della giustizia dal Ministro Carlo Nordio, secondo cui «in un Paese ideale i magistrati non dovrebbero criticare la legge» e sarebbe bene «che la magistratura (…) che si è permessa di criticare le leggi (…) facesse un primo passo di riconciliazione smettendo di criticarle» – guadagnando in cambio, nell’ottica del Ministro, l’esenzione da critiche alle sentenze.
Ora, la distopia di un mondo nel quale ai giudici è preclusa la riflessione critica sulle leggi (e ai politici la critica delle sentenze) si rivela subito inconciliabile con la Costituzione, che prevede la possibilità di ogni giudice di dubitare della conformità della legge ordinaria alla legge fondamentale e di scrivere quell’atto eminentemente “critico”, necessariamente “critico” della legge, che è una ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale.
Ma, al di là di questo, il sogno tartufesco del Ministro – Tartufo è un personaggio che non muore mai e continuamente si reincarna – non ha diritto di cittadinanza nella storia del nostro Paese e nella sua tradizione giuridica, che affonda le radici nell’Illuminismo e nel principio per cui tutto può essere sottoposto a critica e a tutti deve essere riconosciuta libertà di pensiero e di critica.
Nel Paese ideale di Nordio, dunque, la stampa di Md non avrebbe avuto diritto di cittadinanza, non sarebbe neppure esistita.
Ma, come sempre accade, la Storia – con la sua inesauribile varietà – ha la meglio sulla cristallizzata fissità delle utopie e delle distopie e, così, quella stampa non solo è esistita, ma è stata anche molto ricca e vivace.
2. Un ponte tra passato e futuro
Come ha riconosciuto un osservatore esterno a Md e non sempre tenero nei suoi confronti, Vladimiro Zagrebelsky, «la ricca documentazione ed elaborazione portata dai suoi organi di stampa e dalle sue riviste»[1] è stata sempre essenziale all’azione del gruppo.
Quella della stampa è infatti una linea che corre ininterrotta dalla nascita di Md nel 1964 e dalla sua rinascita, nel 1969, sino ad oggi. Una linea sempre parallela all’esistenza del gruppo, anche se non sempre perfettamente coincidente con essa, giacché le cadenze della riflessione intellettuale non procedono sempre all’unisono con quelle dell’azione collettiva.
La stampa si pone come ponte tra passato e presente, tra la storia che stiamo ripercorrendo e l’attualità che ci incalza, tra quello che Md è stata e ciò che può e che deve essere.
Anche se tutti coloro che hanno scritto della magistratura italiana – Edmondo Bruti Liberati[2], Antonella Meniconi[3], Giovanni Palombarini e Gianfranco Viglietta[4] e altri – hanno riservato notevole attenzione alla stampa di Magistratura democratica, manca ancora un lavoro specificamente dedicato a questo tema.
Bisognerà scriverla questa microstoria, inserita nella più vasta storia della magistratura italiana e della giustizia nel nostro Paese, ripercorrendo i temi e i filoni principali della elaborazione intellettuale di Md.
Ragionando del suo garantismo, nato sul terreno del diritto civile e penale del lavoro, della tutela dell’ambiente e poi propagato ed esteso all’intero diritto penale, a partire dalla stagione durissima degli anni di piombo.
Mettendo in luce lo spazio grande riservato all’innovativa giurisprudenza di merito in tema di diritti, che, a partire dalla metà degli anni sessanta, valorizzando la legislazione innovativa di quegli anni, mutava il volto della fabbrica, della scuola, della famiglia “contribuendo” a liberare le strutture sociali dai tratti autoritari e gerarchici che li avevano connotati sino ad allora e assolvendo una funzione emancipatrice di cui oggi la società italiana gode i frutti, spesso senza sapere o ricordare a chi li deve.
Ponendo, infine, l’accento sull’incessante critica e sulla volontà di superamento del corporativismo e della corporazione, con i suoi riti, le sue ipocrisie, le sue modestie etiche e intellettuali.
Di seguito, un rapidissimo sguardo d’insieme e alcune notazioni impressionistiche sulla pluralità delle iniziative, sui loro tratti salienti, sulla loro ispirazione di fondo.
3. I tratti di fondo della stampa “promossa” da Md
Se nel lungo viaggio da Quale giustizia a Questione giustizia molto si è trasformato nei contenuti e nelle tecniche della stampa promossa dal gruppo, alcuni caratteri sono rimasti immutati.
Oggi, come ieri, quella di Md non è una stampa monocromatica. La sua caratteristica di fondo è di essere contrassegnata da una varietà di colori, di essere animata da una pluralità di voci, interne ed esterne alla magistratura.
A volte si pensa e si raffigura Md come un “intellettuale collettivo”. Ma su questa definizione – io credo – dobbiamo intenderci.
Se con l’espressione “intellettuale collettivo” si fa riferimento al desiderio, al gusto di pensare insieme, alla voglia di fare cultura confrontando opinioni diverse, allora quella definizione è pienamente calzante per il gruppo di Magistratura democratica.
Non le si addice, invece, il concetto gramsciano di intellettuale collettivo, come realtà frutto di un “processo organico di costruzione di una volontà collettiva”, come organismo di un pensiero unitario, anche se non monolitico.
Per parte mia, ho sempre visto e vissuto Md come una famiglia intellettuale legata da forti vincoli e legami ideali, che consentono di stare assieme nonostante profonde diversità di natura, di carattere, di cultura e, a volte, nonostante qualche piccola o meno piccola idiosincrasia.
In questa famiglia intellettuale hanno convissuto atei, agnostici, credenti. E ancora intellettuali e giuristi di formazione liberale, marxista, socialista, cattolica.
La stampa di Md ha perciò riflettuto, e riflette fino in fondo, il pluralismo del gruppo.
Così come ne testimonia l’assoluta autonomia – oltre che originalità – culturale.
Ecco l’altro tratto di fondo: una stampa totalmente autonoma.
Culturalmente, prima di tutto, ma anche finanziariamente, perché sostenuta dagli aderenti al gruppo e messa a disposizione di un vasto pubblico di lettori.
Autonomia che contraddice la falsa e banale rappresentazione, alimentata soprattutto in passato, di una Md collaterale o fiancheggiatrice dei partiti della sinistra. In termini storici, una assoluta sciocchezza, liquidata in maniera brillante dal sorridente commento di Paolo Borgna, che con lo spillo acuminato di una memoria fedele ai fatti, nel libro Una fragile indipendenza[5] (scritto insieme a Jacopo Rosatelli), ha smentito la leggenda che negli anni settanta e ottanta Magistratura democratica fosse la cinghia di trasmissione del Partito comunista nell’istituzione giudiziaria, ricordando che in Md convivevano anime culturali e politiche molto diverse e ironizzando sul fatto che, se mai, «nella testa di qualche dirigente di Md il rapporto era rovesciato, il Pci doveva fare quello che diceva Md».
Infine, tra tante miserie dell’oggi, il richiamo e la valorizzazione della stampa di Md ha uno straordinario valore polemico.
Con la sua tensione intellettuale e morale, questa stampa rappresenta infatti la più efficace smentita di una intollerabile vulgata secondo cui “tutti” i gruppi associativi sono oggi divenuti solo macchine di potere e di clientela.
Non è così, anche se per chi fa cultura e non gestione del potere è subito in serbo l’altra accusa, di ideologismo o di politicizzazione partigiana.
Accusa anch’essa infondata solo che si ripensi al tratto pluralista del gruppo, e all’apertura della sua elaborazione intellettuale.
4. L’esplosione policentrica all’inizio degli anni settanta. Quale giustizia, Magistratura democratica e le altre iniziative locali
È all’inizio degli anni settanta che si sprigiona tutta la vitalità della stampa promossa da Md. Ed è la nuova Md – la seconda, nata nel 1969 – a produrre questa esplosione.
È infatti nel 1970 che nasce la rivista Quale giustizia, diretta da Federico Governatori, che proseguirà le pubblicazioni sino al 1979, quando chiuderà i battenti per ragioni essenzialmente organizzative, e senza alcun commiato.
Rivista svelta, incisiva, non accademica, puntuta, corsara.
Rivista di rottura che non si tira indietro rispetto a quelle che allora si chiamavano le interferenze, cioè le critiche dall’interno della corporazione, in fondo le più temute, in quanto provenienti da chi ben conosceva gli interna corporis della magistratura e poteva disvelarne i meccanismi e gli artifici.
Una rivista che si snoda attraverso 51 numeri, alcuni dei quali assolutamente indispensabili per chiunque voglia scrivere della politica del diritto e della storia del giudiziario in quegli anni.
Quale giustizia è scritta almeno per metà grazie a un attento montaggio su temi specifici, monografici, della giurisprudenza innovativa di merito sull’ambiente, sul lavoro, sul diritto penale, sul diritto di famiglia, sulle libertà fondamentali, ed è, per l’altra metà, ricca di saggi che recano firme prestigiose di magistrati e accademici.
Firme che andavano (lo dico solo per intenderci, perché l’elenco sarebbe lunghissimo) da Norberto Bobbio, autore di un saggio intitolato proprio Quale giustizia[6], ad Alessandro Pizzorusso, che curava con la diligenza e la sistematicità del grande studioso un prezioso osservatorio: l’“Obiettivo sulle ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale”.
Tra i numeri memorabili mi limito a menzionare quello doppio, nn. 38-39 del 1977, curato da Salvatore Senese, sul diritto disciplinare, materia da sempre travagliata e decisiva per misurare l’indipendenza effettiva dei magistrati.
Ma, evidentemente, Quale giustizia non bastava se in quegli stessi anni si assiste a una ulteriore fioritura di fogli e di quaderni monografici.
Nel 1972 vede la luce un giornale chiamato, con notevole e forse eccessivo understatement, Bollettino del gruppo Triveneto, diretto da Paolo Dusi, nella cui redazione erano presenti, tra gli altri, Vittorio Borraccetti e Giovanni Palombarini.
Un foglio che sarà seguito, ad alcuni anni di distanza (nel 1981), da un’altra importante iniziativa editoriale promossa dagli stessi Autori: i Quaderni del Centro di documentazione “Mario Barone”, monografie dedicate a temi e problemi ancor oggi cruciali: La violenza sessuale, le donne, la legge (n. 1), La crisi della giustizia civile (n. 4), Iniziativa del pm e controllo sul pm (n. 5), Criminalità e tossicodipendenza. Carcere e misure alternative (n. 6).
Nel 1973, sempre con il nome-simbolo di “Magistratura democratica”, vengono pubblicati, a centinaia di chilometri di distanza, i numeri “uno” di due periodici che esordivano entrambi con il richiamo all’assemblea nazionale di Magistratura democratica del marzo 1973 e all’importante documento in essa approvato.
Documento nel quale si affermava l’impegno per una «difesa intransigente delle libertà costituzionali e della legalità democratica» e si denunciavano i «lividi commenti ed il terrorismo ideologico scatenati dalla destra politica ed economica, culminati nell’invito rivolto al governo ad espellere i magistrati democratici dall’ordine giudiziario “con la ramazza”[7]».
Il primo dei due periodici, intitolato Magistratura democratica, era pubblicato dalla Sezione Piemonte/Valle d’Aosta, diretto da Giangiulio Ambrosini e nella redazione annoverava, tra gli altri, Livio Pepino e Luciano Violante. Nel primo numero spiccava, come secondo articolo, un evergreen delle polemiche giudiziarie: Polizia arresta, giudice scarcera.
La seconda rivista, anch’essa denominata Magistratura democratica e diretta da Luigi De Marco, con vicedirettore Giovanni Palombarini, era stampata a Bari, ma aveva un respiro nazionale e raccoglieva scritti di magistrati e studiosi di tutta Italia.
Nel primo numero, sotto il titolo La scalata repressiva, si informavano i lettori del processo per direttissima per vilipendio dell’ordine giudiziario dinanzi alla Corte di Assise di La Spezia nei confronti di Marco Ramat, Generoso Petrella, Mario Barone e Luigi De Marco per aver distribuito in un dibattito pubblico, dichiarando di condividerlo, il testo di un discorso tenuto da Franco Marrone, di forte critica della magistratura con riguardo ai casi Tolin e Valpreda.
La Rivista chiude i battenti nel 1979 per dissensi interni e differenti valutazioni sulle inchieste riguardanti l’area dell’autonomia, e il gruppo avverte l’esigenza di dar vita a una nuova rivista nazionale.
5. Questione giustizia e Omissis
Per raccogliere il testimone di Quale giustizia e del periodico Magistratura democratica, nasce Questione giustizia su impulso di Pino Borrè, intellettuale e giurista finissimo, tra gli allievi prediletti di Virgilio Andrioli, che per rimanere in magistratura aveva rinunciato alla cattedra universitaria e che fece della Rivista un luogo di permanente discussione e di feconda elaborazione politica.
La Rivista recava, già nel nome, il tratto destinato a distinguerla da quella che l’aveva preceduta. In luogo dell’interrogativo radicale e provocatorio racchiuso nel titolo Quale giustizia, la nuova rivista sceglieva di porre al centro della riflessione la giustizia come “questione”, come campo di problemi destinati a trovare differenti risposte e soluzioni da misurare sul metro della Costituzione e della razionalità giuridica.
Inoltre si sottolineava che la Rivista era, sì, promossa da Md, ma aperta ai più ampi apporti del mondo del diritto e dell’intellettualità italiana e straniera.
Al suo riflessivo impegno Questione giustizia ha tenuto fede nei quindici anni in cui è stata diretta (1982-1997), sino alla sua prematura scomparsa, da Pino Borrè, e nel periodo altrettanto lungo e fruttuoso (1997-2012) della direzione di Livio Pepino, nel quale sono stato, insieme a Gianfranco Gilardi, condirettore del periodico[8].
Dopo il 2012 ad oggi si sono avvicendati alla direzione Beniamino Deidda, Renato Rordorf e infine chi vi parla, giunto ormai al quinto anno di direzione insieme a Rita Sanlorenzo ed Ezia Maccora.
Delle direzioni di Pepino, Deidda e Rordorf ci sono sulla Rivista interessanti testimonianze, che abbiamo voluto raccogliere in tre dense interviste.
Questione giustizia rimane a lungo l’unica rivista promossa dal gruppo, ma nel 1996 nasce l’esperienza di Omissis, rivista quadrimestrale aperta ad avvocati e docenti, romana ma non solo, che pubblica dal 1996 al 2001 con la direzione di Giovanni Palombarini e l’apporto in redazione di molti magistrati romani, tra cui Gianfranco Viglietta, Valerio Savio, Orlando Villoni, Giovanni Cannella, Marco Patarnello e, ancora una volta, chi scrive.
6. Il salto nel web
A lungo Questione giustizia è stata una rivista trimestrale “cartacea”, redatta con i tempi lunghi e i ritmi cadenzati che si addicono ai prodotti di prolungata decantazione.
All’epoca, il rammarico di non poter intervenire tempestivamente sull’attualità era, se non cancellato, almeno attenuato dalla consapevolezza che molti dei contributi pubblicati erano comunque in grado di generare una piccola onda capace di raggiungere anche destinatari lontani e refrattari.
Poi il mare si è rapidamente increspato, tutto è diventato più veloce e frenetico e non c’è stato più tempo per affidare i propri messaggi ai movimenti lenti e lunghi delle onde.
La digitalizzazione ha offerto lo stimolo e l’occasione per una duplice svolta. Dapprima l’abbandono, non senza rimpianti, dell’elegante mondo della carta stampata per trasferirsi integralmente sulla rete. Poi, a far tempo dal 2013, l’affiancamento alla storica rivista trimestrale di una versione quotidiana online della rivista stessa, entrambe aperte all’accesso libero e gratuito dei lettori.
L’ingresso nel nuovo universo del digitale e l’estrema accelerazione impressa alle modalità di presenza di Questione giustizia sono state e sono un’enorme opportunità, naturalmente non priva di rischi e pericoli.
L’accresciuto impegno di redazione di due “prodotti” culturali molto diversi tra loro, come la Trimestrale e l’Online, e la costante consapevolezza della nostra “imperfezione” non hanno reso, però, meno
entusiasmanti la meta e il percorso intrapreso: intervenire sui temi della società, del diritto, della giustizia con l’ambizione di fornire ai lettori sempre nuovi spunti di approfondimento giuridico, di riflessione tecnica, di interpretazione istituzionale.
Ne è scaturita una nuova esigenza: conservare la memoria degli scritti e renderli rapidamente consultabili e disponibili a tutti.
Se le pagine digitali non possono essere ingiallite dal tempo, danneggiate dalla polvere, divenire preda dei roditori, esse sono soggette a un’altra insidia: l’overdose, il sovraffollamento, la sovrapposizione delle informazioni e, in definitiva, il loro disordine e la loro difficile reperibilità.
Di qui l’impegno nella redazione degli indici di Qg online[9] e la fissazione di un traguardo che vorremmo raggiungere in tempi ragionevoli, con la digitalizzazione di tutte le annate della Rivista periodica, dal 1982 sino al suo passaggio sulla rete.
L’obiettivo è procedere oltre, muoversi verso il futuro senza perdere nulla del passato, rendendolo solo più leggero e accessibile delle lunghe scaffalature occupate dalle annate di Questione giustizia.
* Testo dell’intervento pronunciato nella festa per i sessant’anni di Magistratura democratica, svoltasi a Roma nei giorni 9 e 10 novembre 2024.
1. Così V. Zagrebelsky, La magistratura italiana dalla Costituzione ad oggi, in L. Violante e L. Minervini (a cura di), Storia d’Italia - Annali, n. 14 (Legge, diritto, giustizia), Einaudi, Torino, 1998, p. 774.
2. E. Bruti Liberati, Magistratura e società nell’Italia repubblicana, Laterza, Bari-Roma, 2018.
3. A. Meniconi, Storia della magistratura italiana, Il Mulino, Bologna, 2013.
4. G. Palombarini e G. Viglietta, La Costituzione e i diritti. Una storia italiana. La vicenda di Md dal primo governo di centro-sinistra all’ultimo governo Berlusconi, ESI, Napoli, 2011.
5. P. Borgna e Jacopo Rosatelli, Una fragile indipendenza. Conversazione intorno alla magistratura, SEB27, Torino, 2012.
6. Quale giustizia, quale legge, quale giudice, in Questione giustizia, edizione cartacea, Franco Angeli, Milano, n. 1/2004, pp. 1-11.
7. Questo il perentorio invito formulato dal Tempo del 28 marzo 1973. A riprova che le stesse cose ritornano.
8. Una nota personale: è dalla nascita di Questione giustizia che divento testimone diretto e partecipe delle scelte e delle vicende della Rivista. Ed è questa la via attraverso la quale io, che dal mio ingresso in magistratura avevo sempre guardato un po’ in tralice a Magistratura democratica, decido che quello è il luogo del mio impegno. Un percorso, dalla Rivista al gruppo, che credo di non essere stato il solo a fare.
9. Gli obiettivi e i traguardi di cui parlo non sarebbero stati raggiungibili senza l’apporto dei due preziosi collaboratori della Rivista: Mosè Carrara Sutour e Sara Cocchi.
Il primo, dottore di ricerca in diritto comparato, è il colto, attento e scrupoloso curatore dei numeri della Trimestrale; Sara Cocchi, anch’essa dottore di ricerca in diritto comparato e avvocato, cura con dedizione e competenza la versione online, occupandosi anche della sua dimensione fotografica, oltre ad essere autrice di apprezzati contributi pubblicati dalla Rivista.

