Un solo padrone
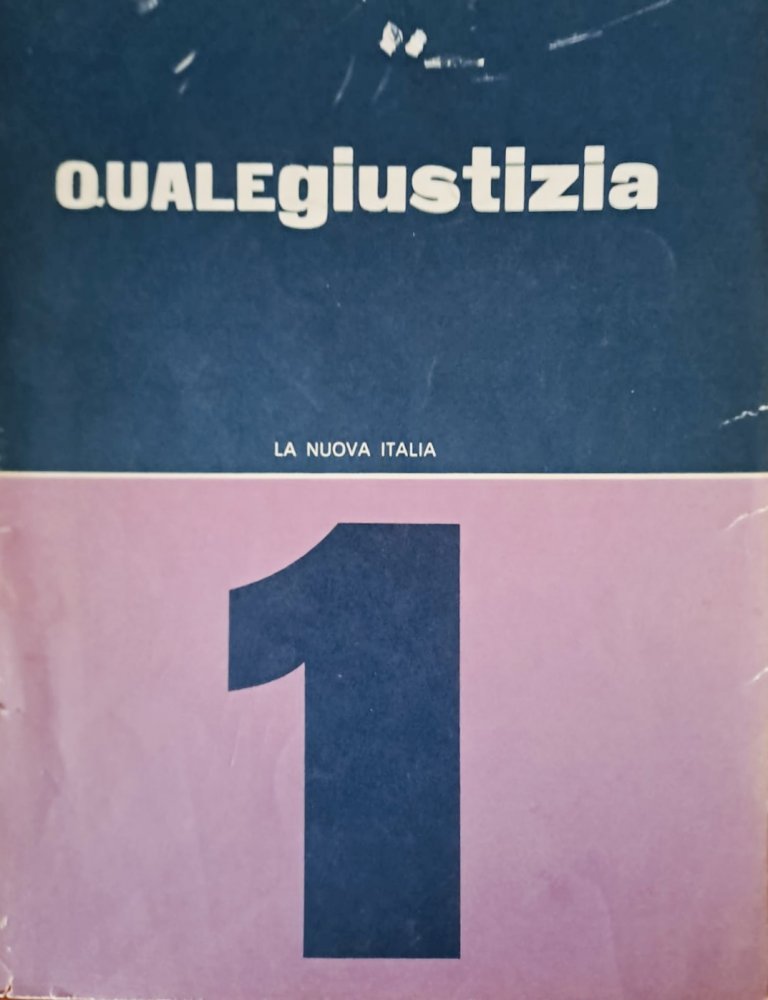
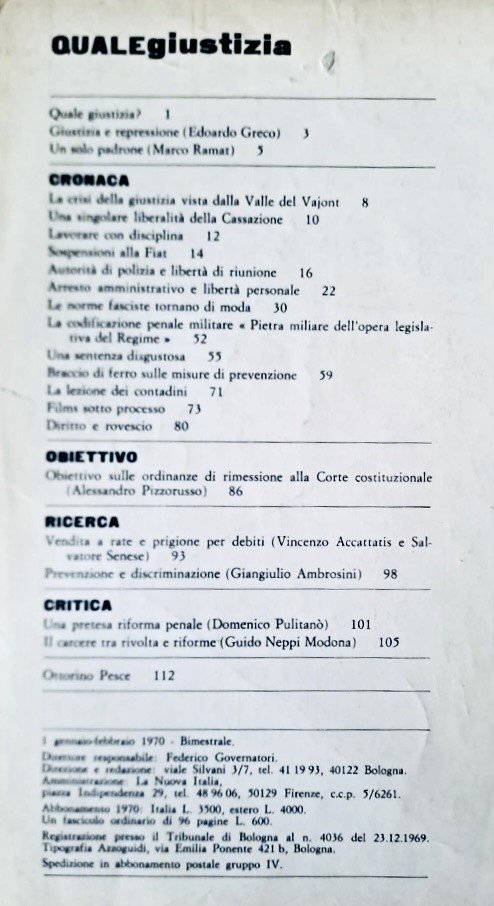
Quando si discusse il titolo della rivista alcuni dei promotori dissero che Quale giustizia si poteva prestare a un equivoco: di far credere che la nostra rivista non volesse uscire dall’ambito settoriale, se non proprio “corporativo”; come dire: “Quale amministrazione della giustizia?”.
Se così fosse, le riserve sul titolo sarebbero giustificate; ma certamente non è così.
Non che i problemi dell’amministrazione in senso stretto della giustizia non ci interessino. Anzi, se ne tratterà spesso; ma se ne parlerà sempre sotto l’angolo visuale più ampio e più profondo dei contenuti della giustizia. In altre parole, non ci ha mai interessato né ci interessa mai il problema della efficienza in sé e per sé della macchina giudiziaria. Sappiamo infatti che l’efficienza della giustizia è, nella migliore delle ipotesi, un valore solo strumentale; quindi un valore neutro; ma spesso diventa di segno negativo se lo strumento è destinato a far funzionare meglio ciò che non dovrebbe affatto funzionare. Senza contare, poi, che tante volte questa giustizia (quale?) sa essere perfettamente efficiente, quando vuole essere esemplare, repressivamente esemplare. Val la pena di ricordare il “miracolo” di giudizi d’appello in processi per reati “da contestazione” celebrati a soli due mesi dal primo grado? D’altro canto, i processi di lavoro durano anni: ecco dunque una giustizia efficiente là, inefficiente qua. Come mai? La domanda è assolutamente ingenua, per noi. Ma non lo è, temiamo, per molti colleghi e per gran parte – in generale – degli “operatori”.
Quando si parla del preteso neutralismo del diritto e della giustizia accade facilmente che ci si attesti nello slogan: “giustizia di classe”, e che ci si fermi lì. Sarebbe certamente stupido negare che, se in massima parte la nostra giustizia è di classe, perché lo Stato è di classe, come impronta di fondo, tuttavia si stanno dischiudendo dei varchi in questo sistema, che potenzialmente “aprono” ad una diversa concezione.
Noi siamo così passatisti da credere che oggi i conflitti nella società siano tutti riconducibili alla lotta di classe tradizionalmente intesa. Il conflitto di fondo è ancora più ampio: è il conflitto tra autoritarismo e libertà, tra apparato e persona umana.
Non si capirebbe altrimenti il perché della contestazione giovanile, in tutto il mondo.
Ed un giorno sarà fatta la storia di come lo Stato italiano e in particolare la magistratura hanno reagito a questo fatto di statura immensa che è la contestazione.
Anche ai giudici sarà chiesto conto del loro operato.
È un po’ rifacendosi a questo giudizio che si comprende un’altra ragione della iniziativa.
È ancora vero che la gran parte dei magistrati ha una provenienza sociale ed economica orientata in senso borghese conservatore; ma le smagliature di questo tessuto sono già evidenti; chi ha avuto la possibilità di girare da una parte all’altra del Paese per dibattiti e incontri nell’ambiente giudiziario, se ne è reso ben conto. Solo che questo fermento, specialmente in molte regioni decentrate e in provincia, è frammentario e sfiduciato, facile alla delusione perché si sente isolato e trascurato.
Ecco quindi un obiettivo: dar forza e conforto a questo fermento; trasformarlo da episodio di ribellismo in impegno coerente, da velleità/rinunzia in realizzazione concreta. Dimostrare che il giudice sperduto in un angolino remoto d’Italia, e che ha per unica “compagnia” una o due paludate riviste tradizionali, non è solo: non è solo quando è in bilico tra il seguire un indirizzo tradizionale confortato da cento precedenti editi, ma che non gli appare giusto, e il mettersi per una strada nuova, lungo la quale però potrebbe temere di perdersi come un pioniere isolato.
Ancora, è abbastanza frequente il caso dei magistrati che sono assolutamente “scissi”; fuori del lavoro sono persone apertissime, curiose del mondo politico, dove vorrebbero che molte cose cambiassero; ma nel lavoro sono chiuse, abitudinarie, rassegnate a che tutto vada com’è sempre andato e al fatto che diritto e giustizia sono nient’altro che il braccio secolare del “sistema”. È non raro, infine, il caso di magistrati seriamente impegnati nell’azione associativa, anche al di là del limite delle rivendicazioni “sindacali”, ma che nella loro giurisprudenza non traducono questo impegno. Il nostro proposito è quello di far capire anche a questi colleghi che sbagliano a scindersi così, che non si possono servire due padroni: far capire, soprattutto che i due padroni ce li creiamo da noi, per nostra poca chiarezza, per manco di vigore.
Perché, di padroni a cui dobbiamo ubbidienza, in realtà ce n’è uno solo: la Costituzione, i valori della Costituzione.
Non crediamo che vi siano magistrati quali consapevolmente e volontariamente si sottraggono a questa ubbidienza creandole l’alternativa dell’altro padrone, che sarebbe la tavola di valori dell’Ancien Régime. Ma non si tratta di far processi alle persone e alle loro intenzioni; questo non ci interessa affatto ed è fuori del nostro raggio d’azione.
Il processo che ci sta a cuore è un altro.
È un processo storico e politico in cui siamo immersi anche noi come protagonisti e come oggetto, e in cui crediamo di interpretare una parte alla quale vogliamo essere fedeli. È il processo storico di assimilazione profonda e capillare dei valori della Costituzione, nella magistratura e nella giustizia. Cento volte abbiamo scritto e detto che forse non c’è nessuna legge la quale non si presti a più interpretazioni, e che il nostro dovere morale, politico e giuridico è di scegliere l’interpretazione più aderente, più capace di realizzare quei valori.
Questa la nostra parte come giudici; questa rivista, non è altro che la proiezione della parte del giudice come l’intendiamo noi. Quale giustizia porta con sé, come connotato essenziale, la ricerca e la proposta dell’alternativa giudiziaria per ogni problema che l’esperienza ci offre.
Ci torna in mente questo bellissimo e amaro ritratto fatto da Anatole France:
«Ho conosciuto un giudice austero. Si chiamava Thomas de Maulan ed apparteneva alla piccola nobiltà provinciale. Era entrato volontariamente nella magistratura sotto il settennato del maresciallo Mac Mahon nella speranza di rendere un giorno la giustizia in nome del Re. Aveva dei principi che poteva credere irremovibili, non avendoli mai mossi. Quando si muove un principio, si trova sempre qualcosa sotto, e ci si accorge che non era un principio. Thomas de Maulon teneva accuratamente al riparo della sua curiosità i propri principi religiosi e sociali»[1].
Ecco perché abbiamo dichiarato “eretica” questa rivista. Il significato etimologico di eresia è “ricerca”, “scelta”. Ma per cercare e per scegliere è necessario lo stimolo della curiosità, il coraggio di essere curiosi.
«Aveva dei principi che poteva credere irremovibili, non avendoli mai mossi»: a quanti uomini, a quanti magistrati si può attribuire questo stato d’animo?
* Testo pubblicato in Quale giustizia, n. 1/1970, pp. 3 ss., poi ripreso in M. Ramat (a cura di), Storia di un magistrato. Materiali per una storia di Magistratura Democratica, Manifestolibri, Roma, 1986, pp. 137 ss.
1. A. France, Monsieur Thomas, in Id., Crainquebille, Putois, Riquet et plusieurs autres récits profitables, Calmann-Lévy, Parigi, 1904, p. 289 (ed. it.: Crainquebille, Putois, Riquet e parecchi altri utili racconti, tr. a cura di G. Marcellini, Sonzogno, Milano, 1920, p. 205) – ndr.

